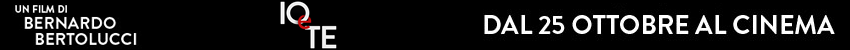di Luchino Visconti
Italia 1957, mélo, 107', b/n. Con Maria Schell, Marcello Mastroianni, Jean Marais, Clara Calamai, Marcella Rovena, Maria Zanolli, Elena Fancera, Lanfranco Ceccarelli, Angelo Galassi, Renato Terra, Corrado Pani, Dick Sanders.
Subito dopo Senso, Luchino Visconti usa il romanzo breve di Dostoevskij per prendere ancora di più le distanze da quel neorealismo a cui lui stesso aveva dato origine: il primo film chiaramente ascrivibile al genere viene infatti quasi unanimemente considerato Ossessione, anche se Michelangelo Antonioni l’aveva di fatto anticipato di poco con Gente del Po, il suo primo cortometraggio. Visconti stesso ebbe modo di parlare di “neoromanticismo” in occasione de Le notti bianche, proprio mentre — quello stesso anno — la critica francese parlava di “neorealismo interiore” a proposito de Il grido di Antonioni: il cinema italiano stava passando gradualmente da una prospettiva che, nell’immediato dopoguerra, per ovvie e molto urgenti esigenze, non poteva che essere collettiva e “sociale”, a un più individuale intimismo (anche se a dire il vero, Il grido è in realtà, curiosamente, l’unico film di Antonioni in cui l’aspetto sociale, pur rimanendo come al solito sullo sfondo della vicenda, ha una certa importanza). Le notti bianche non è certo un capolavoro al livello de Il grido, ma resta un film bellissimo, molto complesso e purtroppo anche molto sottovalutato, nonostante all’epoca si fosse aggiudicato il Leone d’Argento al festival del cinema di Venezia: vanta le intense interpretazioni dei due protagonisti Maria Schell e Marcello Mastroianni (il cui genio d’attore era davvero quello di essere un “uomo normale”, come tanti); la breve ma incisiva apparizione di una Clara Calamai tetra e minacciosa, che non si dimentica; un meraviglioso bianco e nero, nitido e contrastato, di Giuseppe Rotunno; un non memorabile ma funzionalissimo commento musicale di Nino Rota. Visconti trasporta l’ambientazione dalla San Pietroburgo del romanzo ad una Livorno interamente ricostruita — da Mario Chiari e Mario Garbuglia — negli studi di Cinecittà, mantenendosi a metà strada tra realtà (siamo qui ben lontani da una ricostruzione felliniana smaccatamente falsa) ed immaginazione (la ristrettezza dell’ambientazione dà comunque un tono teatrale al film). Proprio in questa scenografia è racchiuso il senso profondo del film, il contrasto tra l’immaginazione utopistica di Natalia, che spera ciecamente in un amore che razionalmente sembrerebbe ormai “impossibile” — l’uomo di cui è innamorata, un inquilino di sua nonna, le ha promesso di tornare dopo un anno e lei lo aspetta invano ogni notte sul ponte dove si erano visti l’ultima volta — e l’attaccamento alla realtà di Mario, che in realtà le consiglia di rinunciare al suo sogno perché si sta innamorando a sua volta di lei. Se il film ha un limite, non piccolo, è nella descrizione, abbastanza frettolosa e superficiale, dell’amore a prima vista tra la donna e l’inquilino. Mentre è interessante e del tutto imprevedibile il passaggio dalla visione pragmatica di Mario, che persuade Natalia a non credere nelle favole, ad un ulteriore “sogno” amoroso che il destino si incaricherà di deludere crudelmente con il ritorno del tanto atteso amante: tale passaggio è sottolineato, ancora una volta, per mezzo della scenografia, che da nebbiosa e quasi funerea assume improvvisamente i tratti di un candido sogno innevato. L’abbraccio finale tra i due innamorati finalmente ricongiunti sancisce, a sorpresa, non solo la vittoria dell’irrazionalità sulla razionalità, ma soprattutto il trionfo finale — a livello individuale e non più collettivo, appunto — dell’utopia. Tuttavia, come osserva Glauco Viazzi: «L’abbraccio finale tra Natalia e l’inquilino non dà la sensazione di un compimento, di una felicità, ma, piuttosto, di una schiavitù. [...] Le notti bianche è la distruzione di un’illusione romantica [...], il dramma del piccolo-borghese che cerca di evadere dalla solitudine, dalla meschinità, dalla tetraggine, traverso la purezza del sentimento, l’illusione dell'amore».