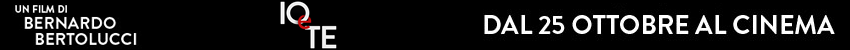di Jacques Audiard
Un prophéte, Francia / Italia 2009, carcerario, 155'. Con Tahar Rahim, Niels Arestrup, Adel Bencherif, Hichem Yacoubi, Reda Kateb, Jean-Philippe Ricci, Gilles Cohen, Antoine Basler, Leïla Bekhti, Pierre Leccia, Foued Nassah, Jean-Emmanuel Pagni, Rabah Loucif.
«Sarebbe una banalità dire che la vita è una prigione. Ma che la prigione sia metafora della vita è evidente: quello che impari dentro, lo utilizzi fuori» (Jacques Audiard). Ogni tanto, per fortuna, capita ancora il miracolo di vedere un film bello, teso, complesso: è successo con Il profeta, che si è aggiudicato il Gran Premio della Giuria al festival di Cannes. Malik è un diciannovenne che viene condannato a sei anni di prigione per aver aggredito un poliziotto. Non sa né leggere né scrivere e non ha una religione. Viene subito preso di mira da César Luciani, leader della gang còrsa che spadroneggia nel carcere, e di conseguenza si trova costretto a svolgere numerose “missioni” che gli fanno meritare sempre di più la fiducia del boss. I compagni di galera iniziano a definirlo un profeta, perché lui è quello che parla, con gli uni e con gli altri, quello che porta i messaggi dentro e fuori, che conosce la gente che può far comodo negli affari. Pur rifiutando categoricamente qualsiasi spettacolarizzazione hollywoodiana, Jacques Audiard accetta gli stilemi del cinema carcerario, che vengono spezzati solo di tanto in tanto attraverso degli inserti onirici (il fantasma dell’uomo ucciso con cui Malik impara a convivere, esattamente come fa con tutto il resto, nella sua cella) che però non si differenziano molto dalla realtà, suggerendo come la realtà sia sostanzialmente un incubo. Lo stile — macchina a mano alla Dardenne e, più raramente, carrelli più sofisticati — cerca di restituire appunto la realtà e di far cadere qualsiasi tipo di barriera tra lo spettatore e la materia narrata: agghiacciante, in questo senso, la prima uccisione con la lametta, che ricorda quasi Niente da nascondere di Haneke per la nuda e cruda brutalità con la quale la violenza viene rappresentata. Il protagonista Malik non è né una vittima del sistema né un eroe: è una persona qualunque (come l’articolo indeterminativo del titolo originale sottolinea) che si adatta per puro istinto di sopravvivenza al mondo in cui viene a trovarsi. Proprio come accade nella vita, Malik impara ad indurirsi, a sfruttare le occasioni che gli capitano, a pensare prima di tutto al proprio interesse, alla propria sopravvivenza, ad uccidere prima che gli altri uccidano lui. Entra in carcere per un piccolo reato (per quanto ne sappiamo, non ha ucciso nessuno) e ne esce non rieducato come il sistema carcerario dovrebbe (in teoria) assicurare, ma al contrario ancora più colluso con il crimine e, soprattutto, molto più potente. I rapporti umani nel carcere infatti sono esclusivamente finalizzati o all’acquisizione di maggior potere o comunque allo sfruttamento di conoscenze e amicizie per rafforzare o mantenere la propria posizione. Anche il “rispetto” tra i boss ed i loro protetti è solo una maschera dietro la quale non si cela altro che egoismo e che cade non appena gli interessi che hanno spinto ad indossarla non sussistono più. Un contesto disumanizzante che Audiard racconta senza falsi moralismi e senza facili metafore, nonché con un rigore ed uno stile che sono difficili da trovare nel cinema contemporaneo (davvero splendida, in particolare, la sequenza dell’uccisione dei capi del boss còrso). Essenziale il contributo degli attori — tutti non professionisti tranne l’ottimo Niels Arestrup — tra i quali spicca ovviamente il protagonista Tahar Rahim, che non solo ha la faccia e il fisico giusti per il ruolo, ma anche talento da vendere e che quindi farà sicuramente strada.